Tito Pomponio Attico, cittadino di Atina?
di Rosanna Tempesta

Foto di Ferdinando Marfella
(Conferenza tenuta al ristorante "C'era una volta" di Casalattico il 21 gennaio 1999, da Rosanna Tempesta, già pubblicata nel libro "Storia della Valle di Comino - conferenze tenute dai soci nelle conviviali. Associazione Culturale Cominium - Cassino 2002)
Nel 1827 il sacerdote d. Giovanni Matassa scrisse: "Montattico è un bellissimo e tondo Castello donato dalla Natura prodiga, posto sulla più bella ed amena collina fra Atina e Valle di Comino e Aquino. La sua aria salubre, abbondanza di squisiti formaggi, con la caccia dei volatili, piccioni selvaggi, pernici, starne ed altri animali di simile fatta. Ivi verso
mezzogiorno e ponente esiste una grandissima selva di elcini chiamata fossa de' Leoni e alle volte vi sono i cinghiali ancora [...]. Sono Settecento anni che il Re Ruggiero di Napoli pigliò la fortezza delle due Sorelle in Casalvieri dopo aver distrutto Aquino, venne in Atina, chiamò dodici persone qualificate per sapere i confini di detta città ed i luoghi Regii, e così incominciarono a descriver: Montattico, fabbricato nel territorio di Atina, da Tito C. Pomponio Attico attinente di Cicerone, e poi riedìficato di nuovo da un cavaliere di Atina e propriamente allorché fu distrutto la prima volta San Nazario [..]1. Da settecento anni (1127?) a questa parte i Montattecesi sì fabbricarono Casale per trovarsi più comodi all'acqua del Melfi, e dirimpetto alla pianura"1.
. Fin dall'antichità, dunque, si è sempre ritenuto che Montattico, vicus originario di Casalattico, abbia preso il nome da Tito Pomponio Attico, letterato romano del I secolo a. C, contemporaneo di Cicerone e suo grande amico che in quel territorio probabilmente possedeva una villa rustica o una semplice proprietà terriera.
TITO POMPONIO ATTICO
Una minuziosa biografia di Pomponio Attico, anche se eccessivamente elogiativa ed entusiastica, c'è stata tramandata da Cornelio Nepote,suo grande amico ed estimatore. La scrisse quando Pomponio era ancora in vita e la completò dopo la sua morte. Numerose altre notizie emergono dalle lettere di Cicerone.
Attico nacque a Roma nel 109 a. C. al tempo delle lotte civili fra Mario e Silla. Uomo ricco e di nobile famiglia, non ricoprì cariche politiche, ma visse tranquillamente, circondandosi degli agi che la ricchezza e il suo gusto raffinato gli procuravano.
Nel 58 da Cecilio, zio materno, ereditò una domus "nei quartieri alti" di Roma, dove le ville delle migliori famiglie si allineavano lungo una strada che andava dal Foro alla Porta Collina (attuale Via del Quirinale e via Venti Settembre)3 e dieci milioni di sesterzi che andavano ad aggiungersi ai due milioni che gli aveva lasciato il padre.
Il senatore Quinto Cecilio era ritenuto il più temibile usuraio di Roma. Era un uomo intrattabile, duro e odioso, tanto che non si poté impedire al popolo di oltraggiarne il cadavere nel giorno del suo funerale. Attico, invece, trovò il modo di vivere con lui, di farsi adottare e di diventare suo erede.
Di Pomponio C. Nepote esalta la saggezza e imparzialità rivelate nel periodo delle lotte civili sollevate da Cinna e in conseguenza delle quali Attico preferì trasferirsi in Grecia con le sue sostanze per lo più mobili, dove poteva proseguire con calma i suoi studi. Vi rimase per circa vent'anni, conducendo una vita agiata, prestando denaro e tornando a Roma solo di rado.
Atene, infatti, da tempo era un centro unicamente culturale, privo di peso politico e di conseguenza in grado di fornire ai suoi residenti l'alibi di totale estraneità alle vicende politiche di Roma. Qui pare entrasse nelle grazie di tutti gli Ateniesi e con il suo denaro contribuì "ad alleviare le loro ristrettezze" pubbliche e private. "Quando l'amministrazione pubblica doveva accendere un mutuo e non trovava condizioni ragionevoli, fu sempre pronto ad intervenire, ma a condizione di non dover esigere da essa interessi iniqui e di non dover concedere dilazioni oltre al pattuito" 4.
Fu chiamato Attico per le doti di affabilità, gentilezza d'animo, per la padronanza della lingua greca che lo faceva sembrare nativo della Grecia e per la cultura che mostrava di possedere.
Gli venne proposta la cittadinanza ateniese, ma egli reclinò questa prova di gratitudine, perché, stando al parere di alcuni, non voleva perdere la cittadinanza romana, assumendone un'altra. Inoltre finché "si trattenne ad Atene, egli si oppose all'erezione di statue in suo onore, ma quando lasciò la città non poté impedirlo 5". In seguito investì il suo patrimonio (che ammontava a più di un miliardo) in Epiro dove organizzò una fattoria per l'allevamento del bestiame.
A Roma acquistò appartamenti, una scuola per gladiatori e una casa editrice per libri di alta cultura. Dichiarò apertamente la sua passione per le lettere e le arti greche quando nel mondo romano esistevano ancora fieri oppositori della cultura ellenica. Fu però anche ammiratore dei grandi romani celebrati per fede, disinteresse e sobrietà. Ne espose le gesta negli "Annali", opera che abbracciava settecento anni di storia e che è andata persa. Scrisse ancora alcune monografie genealogiche sui Marcelli, sui Cornell, sugli Emili e su altre famiglie in vista e un libro in lingua greca sul consolato di Cicerone 6.
Banchiere e grande uomo di affari, fu soprattutto il primo dei grandi editori romani e pubblicò testi latini e greci. A lui si deve la diffusione della cultura greca, soprattutto in campo letterario. Introdusse a Roma la pergamena e ne faceva volumi, vale a dire rotoli, con pagine composte di due o tre colonne di manoscritto, che erano riempite a mano da numerosi schiavi specializzati ai quali pagava solamente il mantenimento. Era servito, infatti, da numerosi schiavi domestici di grande cultura, abilissimi lettori e validi copisti, ma dall'aspetto modesto.
Rifornì di libri la biblioteca di Cicerone e di Terenzio Varrone e quest'ultimo gli dedicò il "De vita populi Romani" in quattro libri e per lui compose "Atticus"1. A lui Cicerone dedicò il "De Amicitia" e il "De Senectute". Quando ci fu la guerra tra Cesare e Pompeo, ancora una volta si mantenne neutrale e non si scagliò contro Antonio, che odiava fieramente Cicerone, anzi protesse i suoi familiari in fuga da Roma e venne incontro alle loro necessità economiche. Il comportamento di Pomponio, però, sostiene Antonio Sartori, non era "frutto di disinteresse, ma un astensionismo attivo, teso a raccogliere l'apprezzamento da ogni parte 8".
In età avanzata sposò Celere ed ebbe una figlia, Cecilia Attica 9, detta anche Pomponia, che ebbe per maestro Quinto Cecilio Epirota. Attica sposò Marco Vipsanio Agrippa, ammiraglio, architetto e uomo politico romano nato ad Arpino. La vita matrimoniale però si svolse fra continue e frequenti liti e rischiò di concludersi con il divorzio 10.
Con Cicerone, che, secondo alcuni aveva conosciuto tra i banchi di scuola e secondo altri in Grecia, scambiò una fitta corrispondenza, non destinata alla pubblicazione (406 lettere raccolte in 16 libri). Dalle indiscrete lettere di Cicerone, pubblicate dallo stesso Attico, emerge una personalità meno idilliaca del cavaliere romano di quella narrataci da C. Nepote: Attico era ricco non solo perché dal padre e dallo zio Cecilio aveva ricevuto cospicue eredità, ma soprattutto perché era un abile agricoltore e un avveduto negoziante.
Il suo genio, commenta Gaston Boissier 11, consisteva nell'arricchirsi dove altri si rovinavano. Vendeva a caro prezzo i libri che faceva trascrivere dai suoi copisti, noleggiava a prezzo elevato i gladiatori alle città che volevano divertirsi, prestava denaro con gli interessi a uomini e a città, soprattutto a molte delle indebitate città orientali, riforniva di statue le più belle e lussuose ville; "le statue che mi hai rimesso", scrive Cicerone ad Attico, "sono sbarcate a Gaeta... mi hai procacciato sì bei tesori con gran diligenza e a buon prezzo "12.
Attico fu abile amministratore delle proprietà di Cicerone. Dava in affitto i suoi beni a prezzo alto, risparmiava più che poteva sulle sue rendite e pagava solo i debiti più urgenti. A lui Cicerone affidò ciò che aveva di più caro, la sua gloria letteraria.
Pomponio morì a Roma nel 32 a. C. a 77 anni, dopo lunga e sofferta malattia. Il suo feretro fu trasportato su una modesta lettiga, senza alcuno sfarzo di funerale, come lui stesso aveva disposto. Lo accompagnarono "tutti i migliori della città e ci fu una grande partecipazione di folla. Fu tumulato nel sepolcro dello zio Quinto Cecilio, al quinto miglio della via Appio 13".
LE EPIGRAFI DI ATINA
Cornelio Nepote, dunque, scrive che Attico nacque a Roma e di certo, tranne l'esperienza ateniese, visse ed operò a Roma. Aveva però certamente dei rapporti con la nostra Valle perché ha dato il proprio nome al territorio che in epoca romana apparteneva ad Atina ed oggi al comune di Casalattico: Monte Attico. Solitamente i toponimi sono una fonte certa di informazione.
Perché questo illustre cittadino romano aveva dei possedimenti nella Valle di Cornino? Il ritrovamento in detta zona di 17 epigrafi della famiglia dei Pomponi e di numerose altre riguardanti famiglie o persone legate a Pomponio da rapporti di parentela potrebbe indurci addirittura ad ipotizzare una sua origine atinate.
Le epigrafi rinvenute e riguardanti le famiglie imparentate con Attico sono della famiglia Celere della quale faceva parte Pilia moglie di Tito Pomponio, una di Cecilio, lo zio materno che gli aveva lasciato l'eredità, dieci dei Rufa 14. Sembra che fosse proprio a causa della parentela esistente con il turbolento tribuno P. Sulpicio Rufo che Tito nell'87 a. C, durante le lotte civili fra Marco e Silla, per non essere coinvolto, si ritirò ad Atene dove rimase fino al 65 a.C.
Le epigrafi sono riportate dal Mommsen, dal Tauleri, da Mancini nel libro "La storia di Atina " e nel "Corpus inscriptionum latinarum ".
Atina fu conquistata definitivamente dai Romani nel 293 a. C. (terza guerra Sannitica), divenne prefettura e fu assegnata alla tribù Teretina di cui sono state rinvenute epigrafi nel territorio oggi appartenente ad Alvito e a S. Donato 15.
La città vantava numerosi uomini di potere e famiglie prestigiose spesso imparentate fra di loro. Nell'orazione "Pro Fianco", Cicerone afferma che in tale Prefettura vi erano numerosi uomini forti così che nessun'altra, in Italia, poteva esserne ritenuta più ricca . Tra essi figurava anche Marco Petreio ultimo ed estremo difensore della repubblica 16. Tra le famiglie prestigiose figurava quella di Gneo Plancio, di L. Munanzio Planco, i Tuberone, i Cecilia, gli Elvi, i Capitoni, i Proculo.
La gens Pomponia era presente nel territorio di Atina ed anche a Cassino dove assunse diversi cognomi: Molo, Mussa, Rufo, Salvio, Tigrane ed altri.
La sorella di Attico, Pomponia, nervosa e bisbetica, sposò Quinto fratello di Cicerone. Quest'ultimo era imparentato con Terenzio Varrone già parente di Attico, perché aveva sposato una Terenzia e con Planco con il quale scambiò fitta corrispondenza (25 lettere di cui 14 scritte da Cicerone e 11 da Planco)17. La parentela poteva risalire alla madre di Cicerone della famiglia degli Elvi presente anche ad Atina come a Sora, a Cassino, ad Arpino e ad Aquino oppure proveniva dalla nonna Gratidia, infatti ad Atina è stata trovata un'epigrafe con questo nome 18.
Di sicuro, dunque, Attico nel territorio di Atina aveva parenti ed amici. Nulla esclude che nello stesso territorio avesse una proprietà. A dimostrare, invece, che egli avesse un'origine atinate abbiamo solamente le epigrafe della famiglia dei Pomponi e delle famiglie con essa imparentate.
LE VILLE DEI RICCHI ROMANI
I membri delle ricche famiglie di Atina e del suo circondario, anche se non imparentati fra di loro e pur vivendo in Roma o in altri luoghi, si conoscevano tutti e diversi di loro possedevano nel luogo d'origine almeno una residenza, quando non si trattava di ville sfarzose.
Tra i possessori di Ville vi era Lucio Munazio Planco, nativo di Atina, generale di Cesare e console. Ne aveva una nella città natale e un'altra a Tivoli, ma la costruì anche a Gaeta.
Orazio, Virgilio e Properzio, non potendosi permettere il lusso delle ville, possedettero luoghi e campi ameni per godervi la pace e il raccoglimento. Cicerone possedeva ville a Tuscolo 19, ad Anzio, a Formia, a Lanuvio, a Pompei, a Cuma, a Sinuessa, a Sessa oltre quella paterna ad Arpino e molte case di campagna. La villa di Tuscolo, già appartenuta al dittatore Silla, era bellissima e sontuosa. Quella di Sessa invece era un alberghetto.
Quinto, fratello di Cicerone, quantunque fosse oberato di debiti, non esitò a comperare una casa nella campagna di Arpino e a costruirvi una villa elegante con bagni, portici, giardini e una biblioteca preziosa per testi latini e greci scelti dal fratello Marco Tullio, che a sua volta era consigliato da Attico. La villa confinava con i terreni di Varrone che si trovavano nell'attuale comune di Casalvieri e in quello di Casalattico.
Come Varrone, Quinto aveva voluto la piscina e la fontana, la palestra o gimnasium e il boschetto verde e ameno. Cicerone afferma che tutti furono consigliati da Attico 20 che rifornì la sua villa e quelle di Quinto e Varrone di statue e di quanto di più bello si potesse trovare in Grecia.
Le ville erano la passione dei potenti e voluttuosi romani e le costruivano sui colli, sui monti, nelle isole e in riva al mare e soprattutto dal I secolo in poi. Quando nell'Urbe incominciavano a farsi sentire i primi calori erano tutti presi dalle smanie per la villeggiatura. Chi non possedeva una sontuosa villa sui monti o al mare aveva perlomeno il piccolo podere o campicello (villula) ove trascorrere gli ozi estivi. Restano celebri le ville di Lucullo, di Varrone, di Tiberio, quella dell'imperatore Adriano a Tivoli, quella di Mecenate 21.
La villa che Varrone possedeva a Cassino fu la più splendida dello scrittore. "Ciò che le conferì maggior lustro fu l'uccelliera e la profusione di ori e di stupendi lavori d'intarsio, con opere di cedro, ove brillava l'armento e il minio con pavimenti in mosaico ricchissimo per la policromia dei colori vivaci. Aveva fatto costruire, inoltre, un orologio con l'immagine di Hesperus e di Lucifer (portatore di luce), in modo da poter distinguere le ore del giorno da quelle della notte"22.
TITO POMPONIO E LA VILLA DI MONTATTICO
Tito Pomponio Attico non poteva mancare di tale indispensabile conforto ritenuto usuale alla vita di un romano agiato. Cornelio Nepote afferma che Pomponio non possedeva ville in Italia all'infuori delle tenute di Ardea e di Nomento, Cicerone invece sostiene che egli possedeva orti suburbani, una villa in Sabina, un'altra a Corfù e altrove. Quella di Corfù era sontuosissima con portici e colonne, statue e pitture. Vi aveva fatto costruire un Ginnasio ove soleva divagarsi conversando d'arte e di studi con i grandi intellettuali della Grecia. Il palazzo era circondato da vaste tenute. Delle altre però e di quanto esse fossero frequentate ben poco sappiamo. Pare che Pomponio al lusso e alla vita mondana delle spiagge preferisse il sollievo dello spirito e la quiete.
Nella sua casa del Quirinale, chiamata Tamfiliana "che era più spaziosa e comoda che bella da vedere", raccolse gli oggetti d'arte che aveva acquistato in Grecia. In essa spesso riuniva a banchetto gli intellettuali di Roma. La sua magnificenza, stando a quanto racconta C. Nepote, gli costava molto, mentre stando a Cicerone "si servivano legumi alquanto ordinari su piatti assai preziosi 23".
Tito aveva dei possedimenti anche nell'aretino confinanti con la proprietà dei Sulpici suoi parenti. Circa a un chilometro a sud di Calbi, infatti, si trova un gruppetto di case rurali detto Pompagnano, a quota 476.
Della villa di Montattico non abbiamo notizie e non è menzionata né da Cicerone, né dallo stesso Attico, né da Nepote. Di essa si è occupato il sacerdote Marsella, nativo di Casalattico, in una monografia storica.
Marsella afferma che il territorio di Montattico era una proprietà di Attico e che su esso esisteva una villa rustica o una semplice casa di campagna che Attico preferiva considerare un rifugio segreto, lontano dalle lotte politiche, anziché fonte di entrate economiche o sfoggio di lusso principesco, perché tutte le sue entrate pare provenissero dalle proprietà che aveva in Epiro (oggi Albania), dai grandi capitali che dava a interesse e dai suoi numerosi negozi.
Le ville rustiche, spesso situate su un'altura per consentire il controllo dei lavori nella tenuta, si svolgevano solitamente intorno ad una corte centrale, con bagni e cucina a Sud, il torchio per l'olio, il fienile a Est, le cantine a Nord, oltre ad ambienti di servizio e al granaio talvolta al piano superiore. Le scuderie e le stalle erano a SO verso l'esterno. Nell'età imperiale gli accessori si moltiplicarono. Non molto lontana dalla villa rustica solitamente sorgeva quella adibita agli usi del signore ed ideata con più dovizia di particolari, servitù ed agi più eleganti e fornita di molte comodità. Non mancavano vaste sale, stanze da letto, bagni e terrazze.
La presenza di una villa romana a Montattico sembra avere una piccola testimonianza archeologica. In contrada Bonificazione, infatti, a poca distanza da Montattico e precisamente sulla china detta "Dirupata", esiste un'antica iscrizione romana incisa su un grosso macigno, che gli abitanti del luogo chiamano la "preta scritta". Su cui si legge: C. POMPONIU C.L. TIGRANUS/ VIAM POLOSTRALEM/ FECIT DE SUA PECUNIA/ H.S.L. CD. (?) / SENE AIUTORE VILI (CORUM). Dalla lettura dell'epigrafe si deduce che Caio Pomponio Tigrante, liberto della famiglia Pomponia, costruì a sue spese una strada rotabile per carri da trasporto a comodità della villa spendendovi forse 450.000 sesterzi e senza alcun aiuto dei villici 24. L'epigrafe se non altro dimostrerebbe che quel territorio era curato e coltivato dagli schiavi e dai liberti della gens Pomponia.
Il sacerdote Marsella, sostiene che la villa doveva essere in località Giardino. "In questo luogo, infatti, afferma, sotto cespugli e burroni si intravede un muro di parete bene intonacato che sembra appartenuto ad abitazione signorile"25, ma di quale epoca? Sappiamo, infatti, che intorno al primo millennio, Atina ottenne dal re Ruggero d'Altavilla il diritto ad edificare a Montattico un castello a protezione delle gole del Melfa, pertanto il muro potrebbe essere di epoca medievale.
Nella zona, in ogni modo, sono stati trovati numerosi mattoni di carattere antico, tavelloni, coperture di tetti ed altro materiale. In contrada Valpiana esiste ancora un forno, rovinato dalle intemperie che potrebbe anche essere di stampo romano.
Il sacerdote Matassa scrive: "Montattico, fabbricato 50 anni prima della venuta di Cristo dal Principe Attico dalle braccia di 500 schiavi che aveva in Roma, da medesimi fu fatto popolare e fin d'allora presero il nome non più di schiavi, ma di veri vassalli di Attico, in dove cuniava monete come a un Re, ed alla giornata si trovano monete d'oro coli'impronta di Attico e di Faustina Augusta Imperatrice f...]" 26.
Nei dintorni della contrada sono stati rinvenuti numerosi idoletti di bronzo, figurine, monete romane, diverse sepolture umane con vasi lacrimali di creta rossastra a forma di anfora con dentro monete ossidate dal tempo, ma posteriori a Pomponio perché su esse si legge il nome di Cesare Augusto imperatore.
Tutto ciò potrebbe solo dimostrare che nel piccolo villaggio si sia svolta una vita romana. Tale ipotesi sembra rafforzata dalla presenza in Contrada Casal Le Mole di un ponte romano sul Melfa in ottimo stato di conservazione e dalla strada romana di accesso al ponte.
L'esistenza di ville nel territorio di Atina è documentata da rinvenimenti del secolo scorso, mentre nei primi anni del Novecento in località Montagna è stata trovata una Domus di età repubblicana e in località Colle alcuni mosaici sempre di età repubblicana. Molte ville dovevano trovarsi a Settignano, ma oggi non appare alcun rudere, perché esse sono state seppellite in profondità dai depositi alluvionali 27.
Marsella, per dimostrare che Attico possedeva una villa a Montattico, esamina attentamente le numerose lettere che intercorsero tra questi e Cicerone, anche se in esse non si fa mai menzione del luogo. Egli sostiene che il riserbo sulla proprietà troverebbe giustificazione nell'indole riservata di Attico e nelle precarie condizioni dei tempi che richiedevano riservatezza per cui non era opportuno nella corrispondenza nominare luoghi e persone. In una lettera scritta da Cicerone, infatti, si legge: "ti scrivo brevemente: non voglio che questo nostro parlar confidenziale venga in mano a chicchessia"2^'2^. Ed ancora: "lacera le mie lettere io farò lo stesso delle tue". Le lettere, infatti, potevano essere facilmente intercettate oppure aperte dagli stessi corrieri.
Alla fine di luglio dell'anno 45 Cicerone, da Arpino, scrive varie lettere all'amico che si trovava in villeggiatura insieme alla figlia Attica gravemente ammalata; In una di queste si legge: "... guarda che comodità l'esser vicini...". Per dirsi vicini, sostiene Marsella, Attico non poteva trovarsi che a Montattico", ma, ancora una volta, nelle lettere il luogo non è nominato. "Quando ero nel Tuscolano, continua Cicerone, mi pareva di parlarvi a viva voce, tanto erano frequenti le nostre lettere; ora ci si presenta la stessa occasione", e conclude: "sed haec coram, ma di ciò parleremo di persona "30.
Dal momento che Attico e Cicerone si scambiavano frequenti visite, notizie e saluti, si può ritenere, insieme con il Marsella, che i due si trovassero in luoghi molto vicini.
Alla fine di luglio, le condizioni di salute di Attica si aggravarono e le lettere tra i due amici si susseguirono in maniera tale che ogni giorno un corriere arrivava ad Arpino con lettere del giorno innanzi. In una di queste Cicerone scrive: "le tue lettere mi danno bene a sperare, ma ormai sono troppo vecchie. Aspetto notizie più fresche"31. Esse erano semplicemente di tre giorni prima, ma se veramente la malata si trovava a Montattico, Cicerone poteva ben pretendere di essere aggiornato sulla malattia, perché un corriere da Montattico, scendendo da Serra Capo Di Colli a Plauto per "le Faete", può tranquillamente giungere in tre o quattro ore. Negli ultimi anni della sua esistenza, sembra che anche Cicerone si rifugiasse per qualche tempo a Montattico presso il suo fidato e sincero amico, perché dopo le quattordici Filippiche pronunciate contro Marco Antonio, fu decisa la sua morte. Per salvarsi la vita vagò tra le sue ville, ma non sentendosi al sicuro chiese consiglio ad Attico il quale in una lettera gli suggerì di dirigersi verso "il ventoso Mimanta oppure all'isola di Psiria, che ha l'Appia alla sinistra"32. La frase è tratta dall'Odissea di Omero dove Mimata, secondo alcuni sarebbe il promontorio dell'Asia minore tra l'isola di Chio e il Golfo di Smirne, secondo altri monte litoraneo di Chio e Psiria sarebbe un'isoletta a Sud di Chio 33.
Marsella sostiene che Attico, utilizzando nella lettera, per ragioni di sicurezza, le parole di Omero, volesse consigliare a Cicerone di rifugiarsi o nella sua villa di Montattico, intendendo per "ventoso Mimata" l'Appennino oppure nella casa di Cicerone ad Arpino, "isola Psiria situata tra il confluente del Liri o del Fibreno" 34. Stando a Marsella per Attico i luoghi più sicuri, ove rifugiarsi, erano Montattico ed Arpino.
Nel I libro del De Divinatione Cicerone scrive: "Cum in Ma fuga nobis gloriosa, Patriae calamitosa, in villa quadam Campi Atinatis manerem... ". Valerio Massimo nel I libro del "De Marco Cicerone exule" conferma: "Inimicorum conspiratione, Urbe pulsus Marcus Cicero, cum in villa quadam campi Atinatis diverseretur f...]35.
Sembra certo pertanto che Cicerone si rifugiasse nell'agro atinate dal quale, nel maggio del 44 a. C, 709 dalla fondazione di Roma, spedì tre lettere, ma si annoiava, sentiva nostalgia della politica e così, dopo breve tempo, tornò a Roma 36. Si era rifugiato nella casa di Pomponio? In quella di Gneo Plancio? In una di sua proprietà posta nell'agro atinate? E difficile pronunciarsi, anche se leggendo Valerio Massimo e lo stesso Cicerone ci sembrerebbe di capire che la villa appartenesse a Cicerone.
IL TEMPIO DELLA CONCORDIA
La tradizione vuole, ci racconta Marsella 37, che Pomponio Attico avesse fatto edificare un tempietto della Concordia, dea alla quale consoli e pontefici tributarono sommi onori dai tempi più antichi. La dea Concordia personificava e simboleggiava l'unione politica, la pace domestica, l'accordo privato e pubblico e aveva il suo tempio principale sul Campidoglio. Che a Montattico potesse esserci un'ara votiva, una specie di Ara Pacis Augustae può trovare conferma nel fatto che nello stesso posto esiste il culto della Madonna della Pace. "Attico, scrisse il sacerdote Matassa, saziato dalle guerre generali e civili si ritirò nella sua villa solitaria tra Santo Padre e Montattico e in tal luogo si portò la dea della Concordia e da tale deità ne è nata la Madonna della Pace che si venera con solennità 38''7.
Verso l'Ottavo secolo, infatti, quando i Benedettini arrivarono nella nostra zona i luoghi di culto degli idoli pagani furono trasformati in chiese cristiane. A Settefrati i monaci cassinensi trasformarono il culto della dea Mefiti ed eressero un tempio a Maria.
La tradizione sul culto della dea Concordia, però, sembra smentita da un'epigrafe rinvenuta sotto il tempio della Madonna della Pace e riportata dal Mommsen e nel C. I. L.: "CVUNDIO NUMISIAE. L. F. PRISCAE/ LI BERII? AEDEM. A. FUNDAMENTIS/ FECIT. CIC. CUM. DEANAE/ POSUITO. L'archeologo padre Antonio Ferrua S. J., con una sua lettera del 1° aprile 1948 comunicava a padre Marsella la traduzione 39: (SE) CUNDIO NUMISIAE L. F. (LIAE) PRISCAE/(SERVUS) AEDEM LIBERI A FUNDAMENTIS/ FECIT; SIGNUM/ DIANAE POSUIT 40.
L'epigrafe quindi attesterebbe il culto di Diana, dea della caccia e delle selve e del dio Libero più tardi identificato con Bacco greco.
L'iscrizione è molto importante e anche se non si può riferire alla Concordia dimostra che in quel luogo esisteva un edificio pagano.
Cicerone ed Attico sono due figure di primo piano nel tramonto della vecchia Repubblica legati da profonda amicizia. Cicerone sempre immischiato in processi e contese, Attico sempre appartato dalle lotte e dai tumulti.
Non tutti hanno scritto in maniera elogiativa su Attico. Alcuni lo hanno accusato di essere taccagno, tirchio, strozzino. Non gli sono state risparmiate accuse e rimproveri come quella di essersi arricchito con mezzi illeciti vendendo libri a caro prezzo, praticando lo strozzinaggio oppure quella di trafficare senza scrupoli sui combattimenti dei gladiatori.
Il 2 maggio 1929, Amedeo Mauri, con l'articolo "Processo a Cicerone" pubblicato su "Il Messaggero" di Roma 41, lo accusava di aver pubblicato l'epistolario di Cicerone su ordine di Ottaviano che in questo modo voleva mettere in cattiva luce l'arpinate. Non abbiamo sufficienti elementi per chiarire la questione, però possiamo affermare che Attico, pubblicando le lettere di Cicerone, ha contribuito a crearne la fama. "Le lettere di Cicerone ad Attico, aveva già notato Seneca 42, non permettono che quest'ultimo vada dimenticato". Pubblicando le lettere del suo amico, afferma, però, Gaston Boissier, "Attico si guardò bene dall'aggiungervi le proprie. Senza dubbio non voleva che si potesse leggere troppo chiaramente nei suoi sentimenti e la sua prudenza cercava di impedire al pubblico la conoscenza delle sue opinioni e l'accesso alla sua vita intima 43".
NOTE
1 N. FRANCHI, Copia di notizie patrie Cominensis raccolte dal fu sacerdote d. Nicola Franchi fatta per incarico dell'ill.mo Cavaliere Signor Carlo Coletti, sindaco di San Donato Val di Cornino, su quella di P. Cristoforo Bevilacqua dei Mn.ri Riformati, 1880, pag. 186. (Il manoscritto appartiene all'ARCHIVIO PRIVATO TEMPESTA- COLETTI).
La chiesa di San Nazario, distrutta dai Saraceni, cadde in possesso dei privati. (D. ANTONELLI, Abbazie, prepositure e priorati benedettini nella Diocesi di Sora - sec. VIII-XV - 1986 -, pag. 49).
2 Si deve intendere che intorno 1127 ci fu lo sviluppo dell'abitato. Il toponimo Casale, infatti, è presente già nei documenti del 1050, come luogo (castello) in cui si trovava la chiesa di San Nazario.(Cfr. D. ANTONELLI, cit., pag. 49).
3 Tracce della residenza romana di T. P. Attico sono state rinvenute lungo il tracciato di Via del Quirinale. In epoca romana, infatti, la zona era delimitata dal rettifilo dell'Alta Semita che, coprendo l'attuale tracciato di via del Quirinale, collegava la città bassa con Porta Collina oggi Porta Pia. L'area fin dall'antichità era considerata di pregio sia per la posizione elevata sia per la salubrità del clima. Sull'area si trovano anche i resti dell'Ara incendi neroniana, della residenza dei Flavi e delle Terme di Costantino. Sulla stessa area oggi si trova il complesso architettonico di S. Andrea, prospiciente il Palazzo del Quirinale, attuale sede dell'Agenzia del Demanio ed edificato tra il XVI e il XVII secolo.
4 C. NEPOTE, Vite e frammenti, Milano, 1980, pag. 280.
5 ibidem pag. 282.
6 ibidem pag. 182.
7 T. VIZZACCARO, Marco Terenzio Varrone ed il Cassinate, Roma, 1954, pag. 30.
8 C. NEPOTE, cit., pag. 183.
9 La figlia di Attica e di Marco Vipsanio Agrippa sposò Tiberio, successore di Augusto
10 U. FIORENTINI, Uomini illustri di Arpino, Arpino, pag. 96.
11 Cfr. G. BOISSIER, Cicerone e i suoi amici, Milano, 1959.
12 M. T. CICERONE, Ad Alt., Libro I, epist. 2.
13 C. NEPOTE, op. cit., pag. 303.
14 Cfr. A. MANCINI, La storia di Atina, A. Forni, 1994.
15 Le tribù furono la prima divisione in caste operata da Romolo e riflettevano i luoghi nei quali vivevano ed operavano. Le tribù rustiche si aggiunsero alle nove originarie e con il passare del tempo divennero più nobili di quelle nove create originariamente in quanto nel 450 Fabio il Censore pose in esse i libertini e tutta la fa miglia romana, donde il sopravvento di quelle rustiche sulle urbane.
16 Cfe., T. VIZZACCARO, cit.
17 Cfr. A. MANCINI, cit.
18 ibidem
19 Cicerone scrisse un'opera filosofica intitolata Le Tuscolanae (lat. Tuscolanae disputationes) cominciata nel 45 a.C. e pubblicata al principio del 44, così chiamata dalla sua villa di Tuscolo dove le discussioni si immaginavano avvenute. 20 M. T. CICERONE, De Legibus, Libro II, da VIZZACCARO, cit., pag. 139.
21 Altri uomini illustri vivevano nel bacino idrografico del Liri-Garigliano- Rapido: Marco Procilo di Interamna, quadrunviro e scrittore di storia al tempo di Pompeo, il grande Plinio, Lucio Papirio di Fregelle che scolpì la statua di Giove capitolino, Quinto e Decio Valeri, il primo filosofo e oratore giustiziato dopo la caduta di Gneo Pompeo, il secondo dottissimo nelle lettere greche e latine. Di Cassino erano le famiglie Lucyeia, Latinia o Pontuleia, gli Agrii, i Lautei, i Papii, gli stessi Pomponi, i ricchissimi Rubrii, i Baboni, i Sansivini ed altre. Erano originarie del luogo la Tribù Teretina, Stellatina e Palatina.
22 T. V1ZZACCARO, cit., pag. 108-144.
23 G. BOISSIER, Cicerone e i suoi amici, cit., pag. 122.
24 A. MANCINI, cit., pag. 831.
25 C. MARSELLA, Un grande romano, Tito Pomponio Attico e la sua villa di Montattico, Sora, 1949, pag. 15.
26 N. FRANCHI, Copia di notizie patrie Cominensis..., cit., pag.. 58.
27 Cfr. MANCINI, cit.
28 M. T. CICERONE, Ad Attico, Libro I, epist. 9.
29 M. T. CICERONE, Ad Att, Libro XVI, epist. 13.
30 Cfr. C. MARSELLA, op. cit.
31 M. T. CICERONE, Ad Att, Libro XIH, epist. 15, 17.
32 M. T. CICERONE, Ad Att., Libro XVI, epist. 13.
33 OMERO, Odissea, Libro III, vv. 215,217.
34 M. T. CICERONE, Ad Att, XII, 2
35 Da A. LAURI, Atina potens, Sora, 1914, pag. 73..
36 M.T. CICERONE, Ad Att., XVI, 15.
37 Cfr. C. MARSELLA, cit.
38 N. FRANCHI, Copia di notizie patrie Cominensis... cit., pag. 187.
39 C. MARSELLA, cit., pag. 57.
40 A. MANCINI, cit., pag. 856.
41 Cfr. C. MARSELLA, cit., pag. 56.
42 SENECA, epist. 21 da C. MARSELLA, cit., pag. 63.
43 G. BOISSIER, Cicerone e i suoi amici, cit., pag. 132.
E' vietata la riproduzione anche parziale dell'articolo.
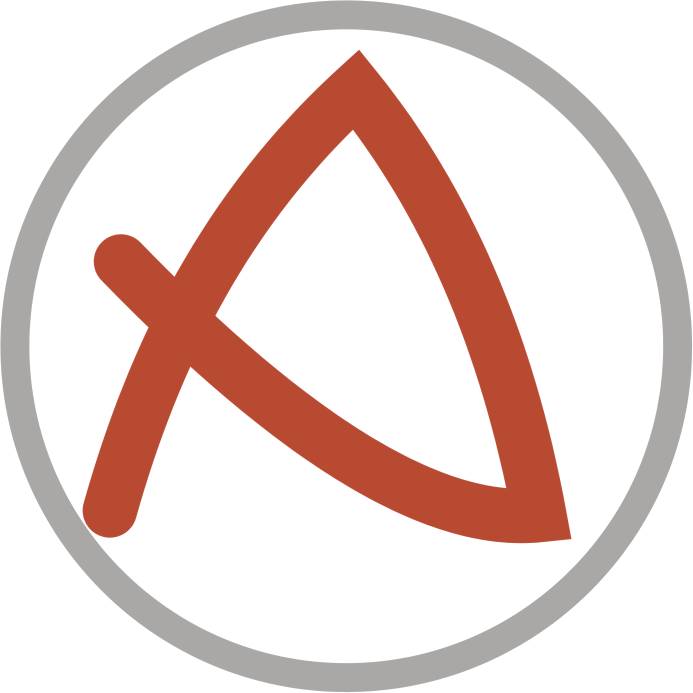





































Comments