Il discorso di Francesco Flamini su Mario Equicola d'Alvito
- ferdinandomarfella
- 26 apr 2024
- Tempo di lettura: 10 min
Aggiornamento: 3 mag 2024
a cura di LUCIANO SANTORO
IN RICORDO DI DOMENICO SANTORO [1]
“Se vogliamo davvero bene agli uomini del passato essi vengono da noi”, affermava Manfredo Tafuri (1935–1994), insigne storico dell’architettura.
Ed è quanto accaduto.
Come riportato a pagina 8 (nota 1) del mio scritto Alvito. Le epigrafi o Mario Equicola e ai Ventuno Provvidi Cittadini, apparso sul Quaderno n._2 – Edizione Speciale per il Ventennale – non era risultato possibile reperire il testo del discorso pronunciato dal prof. Francesco Flamini (1868–1922), docente di Letteratura Italiana nell’Università di Padova, in occasione della Festa in onore del concittadino Mario Equicola che Alvito, a scioglimento di un antico voto, volle celebrare il 29 settembre 1907.
Soltanto in questi giorni, in circostanze che hanno del singolare, ho rinvenuto il testo integrale del discorso in parola sul n._42 del Fanfulla della Domenica del 20 ottobre 1907, periodico letterario a tiratura nazionale la cui pubblicazione, come si sa, cessò nel 1919. Sono quindi lieto di far rimessa all’Archeoclub – sede Val di Comino – del testo in parola perché, volendolo, possa disporne la pubblicazione sul prossimo Quaderno ad integrazione del richiamato articolo sull’importante avvenimento letterario.
Un inchino all’insigne prof. Flamini, oratore elegante fornito di singolare competenza nel campo di questo glorioso periodo della storia letteraria italiana, salito ancor giovane nell’Ateneo di Padova sulla cattedra già illustrata da Giacomo Zanella e Guido Mazzoni e un plauso ancora alla Commissione Organizzatrice della Festa Equicolana composta, vogliamo ricordarlo a futura memoria, dagli alvitani Vincenzo Mazzenga (1863–1942) Consigliere della Deputazione Provinciale di Terra di Lavoro, presidente, dr Valerio Castrucci (1864–1945), ins. Ettore Persichetti (1870–1934), prof. Vincenzo Santoro (1876–1913), prof. Domenico Santoro, segretario.
Alvito, 8 dicembre 2022 Luciano Santoro

MARIO EQUICOLA D’ALVITO
di Francesco Flamini
(Professore alla R. Università di Padova)
In questi giorni Alvito ha consacrato una lapide alla memoria del suo cittadino più famoso. Sotto il porticato dell’antica sontuosa dimora dei duchi Gallio, divenuta sede della civica amministrazione, si legge ora, a sinistra del riguardante, una bella epigrafe in onore di Mario Equicola, che «esule co’ suoi profughi signori, servì con fede gli Estensi e i Gonzaga in molteplici uffici di legazione, di magistero, di governo», e «caro a principi e a pontefici, amico al Bembo e all’Ariosto, legò durabilmente il suo nome alla cultura del glorioso Rinascimento».
La linda cittadina, che in sito pittoresco s’adagia sopra un declivio dominato dalle maestose rovine del castello dei Cantelmo, in faccia ad una gran vallata tutta verde, sparsa di grosse borgate e cinta d’ogni intorno dai monti, ha festeggiato con decoro pari all’entusiasmo quest’avvenimento letterario. Fino a tarda ora per la via principale del paese, graziosamente illuminata, il buon popolo alvitano s’è accalcato gioioso; non senza qualche evviva (in ispecie nelle vicinanze del Circolo Mario Equicola) all’antico segretario e precettore d’Isabella d’Este Gonzaga. Sorrideva lo spettatore; ma, al tempo stesso, correva con la mente al dantesco fannogli onore, e di ciò fanno bene.
Poiché l’apporre un ricordo dell’autore della Cronaca di Mantova e del Libro di natura d’amore sulle pareti del Palazzo Comunale della sua città, è stato senza dubbio una buona idea. Quel nome, inciso nel marmo, varrà a rievocare alla fantasia di chi visiti il vecchio feudo dei Cantelmo l’età in cui l’Italia, politicamente serva, fu intellettualmente sovrana; l’età che vide gl’Italiani, in tutte le altre cose discordi, affratellati nel desiderio di vivere in mezzo ai più nobili godimenti dello spirito. Mario Equicola n’è un rappresentante assai fedele, che incarna di essa ogni aspetto; così che nel riandarne la vita, nel rileggerne le tante scritture volgari e latine, ci par di rivivere a quei tempi. Con lui noi torniamo in qualche modo ad aggirarci fra le erudite galanterie e gli artistici sollazzi delle corti di Mantova e di Ferrara, e lo vediamo trascorrere per sale adorne d’affreschi, di bronzi, di marmi, lo vediamo assistere a spettacoli allietati da tutti i sorrisi dell’arte, lo udiamo conversare in quei convegni di dame non meno addottrinate che eleganti, a cui interveniva anche il fiore dei gentiluomini letterati della penisola.
Come il suo più celebre collega ed amico Baldesar Castiglione, anche l’Equicola ci offre in sé stesso il tipo caratteristico del nostro cortigiano del Cinquecento, in cui un’eclettica e quasi enciclopedica cultura s’accompagnava alla più ricca varietà e molteplicità di tendenze, e la versatilità più singolare ad uno schiettamente italico equilibrio dell’ingegno nell’armonia delle sue facoltà, tutte ad un tempo vigili ed operose. E anche l’Equicola scrisse di cortigiania e di bel costume; in un libro che se non può reggere al paragone del lodatissimo del cavaliere di Casatico, ci dà nondimeno un’immagine della vita spiritualmente raffinata delle corti italiane di quel secolo.
Chi non ha presente il novelliere di Matteo Bandello, che, facendoci sfilare dinanzi principi e guerrieri, scrittori ed artefici, rappresentando nel chiuso delle pareti domestiche le grandi dame del tempo, ci riconduce in seno alla società coeva all’autore, in mille diversi modi atteggiata nella vita familiare e cittadinesca d’ogni giorno? L’Equicola – che nell’enumerazione di letterati inserita da Lodovico Ariosto nel suo poema appare un nome vano, una pallida ombra evanescente – sembra vivere e spirare, invece, là dentro, in codeste novelle del Boccaccio lombardo, dov’è ritratto quale veramente egli fu; cioè come un piacevole ingegno, un motteggiatore arguto, degno di stare a fianco a quel cardinale da Bibbiena, suo grande amico, al quale la porpora non impediva d’essere un bell’umore, d’ammaestrare all’uopo gl’istrioni cari a papa Leone X e di scriver commedie buffonesche quanto le pochades moderne.
Mario Equicola ci dà, come ho detto, l’immagine dei tempi: i tempi spiegano e giustificano l’uomo, lo scrittore. Vi offende nella sua letteraria suppellettile così copiosa quello che innegabilmente essa contiene d’artificiato, di lezioso e di pedantesco? Vi pare strano che un uomo come lui, non ignaro certamente dei fini dell’arte e del nobile ministero delle lettere, si spassasse a lamentare in versi latini la morte della cagnoletta usa a scodinzolare sulle ginocchia della marchesa di Mantova? Ebbene: pensate che quella bestiuola ebbe l’onore di una tomba con relativo epitaffio, e che ben diciassette poeti intonarono in suo onore le più flebili querimonie; pensate che anche il dittatore del buon gusto, il grave autore della Istoria Veneta e delle Prose della Volgar Lingua, appartenne al novero di coloro che andavano mendicando il sorriso delle dame coll’arzigogolare in rima su quisquilie così fatte o, come altri verseggiatori di quel tempo, sulle tossi e le infreddature della loro bella, sulle mosche che la molestavano d’estate. Bernardo Accolti a cui l’Equicola era affezionato anche in grazia dell’ammirazione che (testimone l’Ariosto) provava per lui, Bernardo Accolti che, quando improvvisava pubblicamente in Roma, attirava intorno a sé tanta folla, da far chiudere le botteghe come in giorno di festa, deve l’appellativo di Unico a sonetti, tra cui uno, famosissimo, prende argomento, non per celia, da un carciofo!
Detto questo, s’attenuano agli occhi di ogni equo giudice certi difetti delle opere latine e volgari dell’Alvitano. Chi oserà rimproverargli troppo il vuoto e l’accademico di qualche suo discorso, di qualche suo trattato, dato ravviamento essenzialmente retorico degli studi sopra la latinità, che vigeva fra noi nei primi del Cinquecento? Le orazioni che solennemente si recitavano allora dai dotti in questa o quella occasione, avevano nella sostanza così poco di serio! La forma era tutto, e si sa che l’esser buon ciceroniano pareva a taluno maggior fortuna che l’esser re o papa. Leone X espresse il desiderio di leggere le esortazioni del nostro Equicola contro il Turco, minacciante nella sua oltrapotenza e oltracotanza l’Italia, non per altro se non perché pensava fussino belle, cioè pensava che fossero un bel saggio di prosa latina.
Io non dico che l’opera principale di Mario di Alvito, che fu per un trentennio il lavoro suo di tutti i giorni, e che solo un mese avanti di morire, nel 1525, egli s’indusse a dare alla luce, sia nel rispetto dell’arte un capolavoro. Il Libro de natura d’amore, farraginoso e per la pesantezza dello stile poco piacevole a leggere, può benissimo non piacere a noi, come non piacque a quell’arguto ingegno di Traiano Boccalini. Senza dubbio, il vistoso apparato erudito e la gravità dell’esposizione, alquanto pedantesca, hanno sapore di forte agrume al nostro palato di uomini moderni, più schifiltosi e avvezzi a ben altro cibo.
Ma nel Cinquecento piacevano: tanto che l’Equicola s’ebbe allora l’encomio anche di giudici non facili, come Anton Francesco Doni, e il suo trattato nel corso di quel secolo ottenne l’onore di quattordici ristampe. Appunto per questo lo ricercano tuttora gli studiosi, che sanno di poter ripescare in quel mare magno molte belle cose per la storia delle idee e del costume. Poiché l’Equicola, mediante una scorribanda «nei campi della filosofia e della teologia, ... nei prati degli oratori, nei boschetti dei poeti», ci ha dato in quest’opera, che, al par dell’altra più breve intorno al cortigiano, attesta in lui onestà d’intendimenti e varietà di dottrina, una trattazione dell’amore organica e compiuta, quale non era stata fatta ancora, né fu ritentata in seguito da alcuno; e in essa il tema appare riguardato da ogni aspetto, non senza accenni curiosi, sia alle più acconce fogge di vestire degli amanti, sia a quella galante ermeneutica dei fiori e dei colori, ch’era delizia, nel primo Cinquecento, della nostra società aulica e colta.
E qualità di erudito abile a raccogliere e coordinare quanto si rilevi da opere sacre o profane, qualità (lodate da quel sommo che fu il Muratori) di storico che attinge direttamente alle fonti e le notizie raccolte vaglia con discernimento sottile, dà a divedere l’Equicola in altre sue scritture, segnatamente nella Cronaca di Mantova, dettata con serietà d’intendimenti, con larghezza d’indagine, con veridicità che in un cortigiano fa meraviglia.
Perciò al tributo di riverenza che gli è stato reso in questi giorni dai suoi concittadini si sono associati quanti le insigni memorie nel Rinascimento hanno in pregio. Ed è bello che, come un giorno da Venezia, estremo propugnacolo dell’italianità in ferrei tempi conculcata, giungeva, all’Alvitano la laurea di poeta unitamente agli speroni d’oro di cavaliere, così oggi, nell’Italia libera ed una, la parola della lode sia venuta alla sua memoria da Padova, che, grazie al suo Ateneo, può dirsi l’erede delle glorie scientifiche della Repubblica di S. Marco. Per tal modo l’omaggio, trascendendo i confini del feudo che fu dei Cantelmo, s’è allargato alla provincia, anzi alla regione: a tutta quella parte più meridionale d’Italia, negletta e talvolta calunniata, eppur così fertile d’ingegni vividi o profondi, che come oggi aiuta di valide forze manifeste e latenti il moto ascensionale infrenabile del popolo italiano, così nel secolo stesso di Mario Equicola dava alla madre patria a Sessa un Nifo, a Sora un Baronio, un Tansillo a Venosa, un Bruno a Nola, a Napoli un Giambattista della Porta.
Rappresentante ammirato di questa cultura del Mezzogiorno presso le altre regioni d’Italia, e non d’Italia soltanto, fu nelle sue peregrinazioni per la penisola e nella sua ambasceria a Blois presso il re di Francia anche Mario Equicola educato in Alvito dai Cantelmo, suoi signori e congiunti, membro dell’Accademia Pontaniana di Napoli, amico di Jacopo Sannazzaro e di Agostino Nifo.
Sullo sfondo della vita cortigianesca d’Italia nella prima metà del secolo decimosesto la sua figura spicca appunto perciò più rilevata. Figlio del Mezzogiorno, ove la feudalità perdurò così tenace, e, come tale, erede in qualche modo dello spirito cavalleresco del medio evo, l’Equicola rinnova in campo e nel chiuso delle fortezze gli antichi esempi di fedeltà al sovrano e di valore guerresco: al tempo stesso, appare uomo del Rinascimento nella diplomatica destrezza di cui dà prova nei maneggi politici, e nella duttilità dell’ingegno imbevuto di classica cultura ma consapevole d’ogni tendenza o necessità dell’età che fu sua. Il nome dell’Equicola è indissolubilmente legato a quello della più celebre fra le gentildonne italiane del Rinascimento: l’incomparabile Isabella d’Este Gonzaga, della quale fu precettore caramente diletto. Nella corte di Mantova, ostello di tutte le Muse e nido d’ogni cortesia, Mario d’Alvito per tal ragione troneggiò rispettato ed ascoltato fra la turba dei cortigiani. A lui, per ottenere favori dalla dotta marchesana, facevano capo i più cospicui letterati d’Italia; lui Isabella inviava a Milano, a Napoli, a Roma con le più importanti e più delicate missioni; da lui ella volle essere accompagnata in un suo viaggio per la Provenza; lui elesse segretario, e difese contro le denigrazioni degli invidiosi di tanta fortuna.
Un vivo raggio, pertanto, della gloria di Isabella Gonzaga avvolge e circonfonde tutta quanta, ingrandendola ai nostri occhi, la figura dell’Equicola: è la luce, da lei così nobilmente riflessa, del Rinascimento per cui l’Italia fu ai popoli maestra d’eleganza e di dottrina. E in quel meriggio magnifico, di cui tutte le genti civili ebbero ad ammirare lo splendore e a risentire l’efficacia, anch’egli, nella gran folla degl’Italiani che attesero allora infaticabilmente all’opera delle lettere, richiamò sopra di sé gli sguardi degli stranieri: il suo trattato d’amore, fin dal Cinquecento stesso voltato in francese da Gabriele Chapuis, diventò un libro classico pei nostri vicini d’oltralpe, che s’ingegnavano d’imparare da noi la raffinata eleganza del costume cortigianesco. E anche più tardi, nel secolo in cui il Boileau, il Racine, il Corneille faranno, a imitazione degl’Italiani del Rinascimento, opera d’arte squisita seguendo al tempo stesso la tradizione nazionale nelle ruelles dove le dame parigine escogitavano, adagiate su molli strati, nuove mode e vocaboli nuovi, o andavano in visibilio nel legger la relazione veridica del Regno di Galanteria del buon abate d’Aubignac, sarà letto e sfruttato, insieme col commento del Ficino al Simposio di Platone, il Libro di natura d’amore dell’Equicola; così come il «galante», quale vagheggerà la società dei précieux e delle précieuses parodiata dal Molière, apparirà congiunto strettissimo del «cortegiano» di Baldesar Castiglione e del nostro Mario d’Alvito.
Al quale resta dunque, in conclusione, il vanto d’aver cooperato a diffondere di là dai nostri confini l’educazione del sentimento e del gusto, la notizia della cultura umanistica e di quello spirito assimilatore al tempo stesso e innovatore, ch’era proprio degl’Italiani dei tempi di Giulio II e di Leone X, quando tutta Europa leggeva ammirando il Furioso, e le tele e le statue de’ nostri sommi stupivano il mondo, e Venezia, all’apogeo dello splendore, insieme coi nuovi capolavori dei Bellini, del Carpaccio, del Giorgione, di Palma il Vecchio, divulgava, grazie all’opera indefessa d’Aldo Manuzio, antichi capolavori d’altro genere più famosi.
L’Italia durante il maturo Rinascimento richiamò in vita quelli ch’erano stati gli ideali estetici d’un suo grande passato di gloria, e fu cagione del loro spontaneo, anche dove effimero, trionfo presso tutti i popoli civili. All’Equicola spetta un posto onorato nella schiera degli umanisti che condussero allora la nostra nazione a adempiere codesto ch’è il suo naturale e peculiare mandato nel mondo. Gli spetta, non fosse altro, per esser egli stato l’anima della società che s’adunava in geniali convegni intorno alla genialissima Isabella, per aver atteso con amore a raccogliere testi a penna ed a stampa degli scrittori dell’antichità risorta a vita novella.
E, riguardata nel suo complesso, l’opera di Mario d’Alvito appare nutrita di varia dottrina e tutta, per questo o quel rispetto, non trascurabile. Meritava l’Equicola che di lui si ricordassero, come ora hanno fatto, i suoi concittadini: meriterebbe parimente il Libro di natura d’amore di riveder la luce in miglior assetto del testo, in veste tipografica più nitida e più decorosa, con un commento che potrebbe riuscir prezioso per la storia del costume, ed uno studio sulla fortuna avuta in Francia, in Ispagna e, credo, anche altrove dal diffusissimo trattato, che sarebbe una nuova pagina non incuriosa della storia (ancora da fare in tanta parte) delle relazioni letterarie internazionali nei secoli del Rinascimento.
Questo è nei voti, ed è da sperare, che si faccia quanto prima. Sarebbe un nuovo monumento alla memoria del celebre Alvitano, da porre a fianco a quello che con la sua monografia sulla vita e sugli scritti di lui ha già saputo innalzargli un conterraneo, Domenico Santoro; monumento non di freddo marmo, come la lapide testé inaugurata, ma fatto d’amore e di dottrina, eretto, sul fondamento dell’investigazione erudita, per virtù della parola che ricrea scolpendo, e i morti rievoca dai silenzi del Lete nel consorzio dei vivi.
Riproduzione del testo del discorso del prof. Flamini sul n.42 del “Fanfulla della Domenica” – 20 ottobre 1907 – a lui indirizzato.
[1] Domenico Santoro (Alvito, 1868 – Foggia, 1922) è stato filologo e storico italiano.
Il 21 aprile 2022, ad Alvito, si è celebrato il centenario della sua scomparsa.
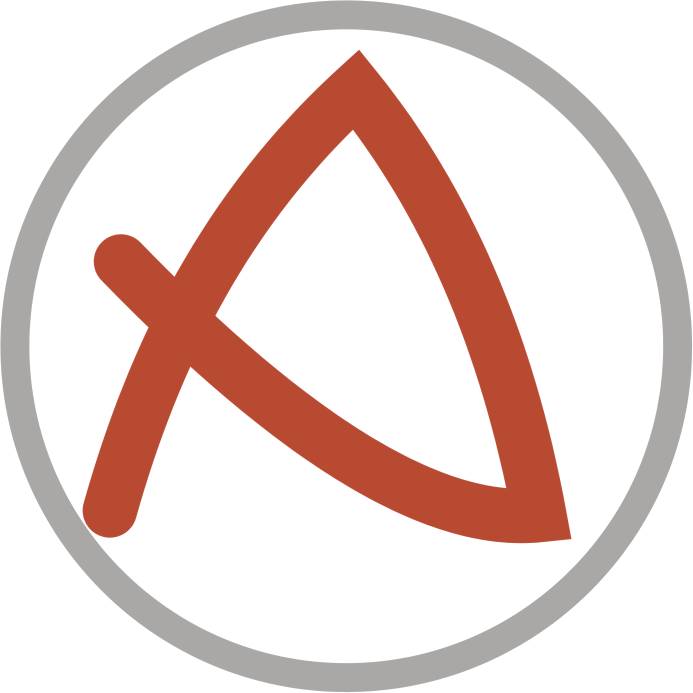





































Comments